La Repubblica del cittadino Gambazzocca
“Il marchese Gambazzocco passeggiava, in ora a lui insolita, sulle mura di Crema, con aria d’impazienza, come di persona cui tarda di aspettare qualcuno”. Ci è presentato così, da Francesco Sforza Benvenuti, il personaggio chiave della nostra vicenda. Che non è una vicenda da poco: è quella della fine del governo della Serenissima a Crema. Chi sta aspettando Fortunato Gambazzocca, quella mattina del 28 marzo 1797, contando su un avvistamento più agevole dall’alto delle mura? E chi è Fortunato Gambazzocca? Forse però è meglio dire prima qualcosa su quello scenario storico generale.
Il contesto storico
Siamo nel biennio della prima campagna d’Italia, combattuta dall’armata francese guidata da Napoleone. Tra il marzo 1796 e l’ottobre 1797, tutto cambia nell’Italia settentrionale e in parte di quella centrale. Sui terreni di guerra si susseguono le vittorie francesi. Le principali sono quelle di Montenotte, Millesimo, Mondovì, Lodi, poi l’occupazione di Milano, poi Rivoli e la capitolazione di Mantova. Segue la spedizione nell’Italia centrale, dove il papato perde le legazioni di Bologna, Ferrara e Romagna, oltre ai possessi di Avignone. Poi, forzato il Tagliamento, i francesi iniziano una marcia vittoriosa verso Vienna, fermandosi a Semmering, a cento chilometri dalla capitale austriaca. Questa prima campagna d’Italia termina nell’ottobre 1797, con il trattato di Campoformio (o Campoformido). Anche la Repubblica di Venezia è investita da questi sommovimenti, in modo molto negativo.
Riguardo alla parte lombarda dei territori della Serenissima, fin dalla metà del 1796 le forze francesi avevano iniziato a stanziarsi nel bergamasco, nel bresciano e nel cremasco con truppe stabili e con dei poteri di influenza e di condizionamento sempre maggiori. La soluzione della nomina di un Provveditore Straordinario di Terraferma, Francesco Battaglia (o Battagia) e un precario sistema di rapporti tra le residue magistrature venete e i poteri militari francesi avevano impedito, fino al mese di marzo 1797, che in questa parte di terraferma si creassero istituzioni ufficialmente sottratte al governo dogale e poste sotto l’egida francese. I podestà Alessandro Ottolini a Bergamo, Pietro Alvise Mocenigo a Brescia e Giovanni Battista Contarini a Crema (i primi due sono indicati a volte come vice podestà) in questo periodo di transizione non vengono destituiti e nei mesi che vanno dalla metà del 1796 al marzo 1797 la Repubblica di Venezia continua, almeno formalmente, a esercitare la propria sovranità su questi territori.
La storiografia prevalente concorda sul fatto che Venezia, fin dall’inizio delle operazioni militari francesi in Piemonte nel marzo 1796, sbaglia completamente e disastrosamente le sue strategie diplomatiche e militari. L’aver optato per una “neutralità disarmata”, come dice il Benvenuti, è stato per le insegne di San Marco “il peggiore dei sistemi”, anche in ragione di quei “momenti procellosi”. Infatti, col trattato di Campoformio, la Repubblica di Venezia cessa del tutto di esistere, anche a seguito degli accordi del trattato di Leoben dell’aprile precedente. Prima di Campoformio, alla fine di giugno del 1797, i territori di terraferma veneta in Lombardia (le tre province di Bergamo, Brescia e Crema) erano già entrati a far parte della Repubblica Cisalpina.
L’Europa è sconvolta. Questo fronte italiano, almeno al principio, non era per l’esercito rivoluzionario quello principale, che era considerato, in questi inizi del turbine napoleonico, il fronte del Reno. Non è una guerra come un’altra. Sono clamorose l’audacia, la fulmineità e la spietatezza, manifestate spesso con gli assalti alla baionetta, con cui questi soldati sans Dieu et sans peur riescono a capovolgere sul campo, a loro favore, anche le situazioni più difficili. Forse perché ciascuno di loro sa di avere “nello zaino un bastone di Maresciallo”. Generali e ufficiali giovanissimi (lo stesso Napoleone è nominato generale di corpo d’armata a ventisei anni, pochi mesi prima di partire per la campagna d’Italia), spesso venuti dal nulla, sbaragliano gli imparruccati generali e ufficiali avversari, onusti di blasoni aviti e spesso portatori, sui campi di battaglia, di una spocchiosa pusillanimità bellica. Non è solo un fenomeno militare. Ci sta dietro una nuova realtà sociale. Il mondo non sarà più come prima.
Dove arrivano questi soldati della rivoluzione, si bruciano i diplomi di nobiltà e si impongono pesantissime “patrimoniali”, come si direbbe oggi, ai notabilati economici dei vari territori “liberati” (il concetto di “liberazione” è storicamente molto risalente), che sono quasi del tutto composti da rentier fondiari aristocratici, parassitariamente insediati nei poteri locali. Si depredano chiese e vescovati. Si chiudono e si sgomberano i conventi, trasformandoli in caserme e depositi di cavalleria, rimandando a casa loro un gran numero di frati di tutte le tipologie e di suore appartenenti soprattutto alle casate nobili del luogo, casate che faticavano a munire tutte le loro rampolle di dote e quindi di attrattiva matrimoniale. Nelle piazze principali si issano gli alberi della libertà. Si canta la marsigliese. Si inneggia alla Dea Ragione. Si tolgono i rettori e i precettori religiosi dalle scuole e si sostituiscono con personale laico. Dovunque risuonano tre parole che terrorizzano i codini, a Crema i goghi: libertà, uguaglianza, fraternità. Tutti hanno il titolo di cittadino, non più di principe, duca, marchese, conte, visconte, barone e via dicendo. Certo, i francesi saccheggiano, rubano, fanno violenza. Non è una novità. Tutte le forze di occupazione lo hanno fatto, lo fanno e lo faranno. Forse lo fanno con una avidità particolare. Soprattutto, espropriano i beni ecclesiastici con confische e requisizioni.
Napoleone a Crema
Prima che Fortunato Gambazzocca scrutasse l’orizzonte dalle mura di Crema, in quel 28 marzo 1797, l’anno precedente Napoleone, da Crema, ci era passato di persona alla testa del suo esercito. Dopo l’armistizio di Cherasco col Regno di Sardegna del 28 aprile 1796, Napoleone punta infatti le sue forze sulla Lombardia austriaca e supera il Po a Piacenza l’8 maggio. Isola così Milano, che viene poi occupata. Quindi insegue gli austriaci, guidati dal generale Beaulieau, in ripiegamento verso il Mincio. L’esercito austriaco è in fuga. Nel territorio cremasco si verificano devastazioni, violenze e saccheggi ad opera di queste truppe austriache in rotta. Il nostro podestà e capitano, Giovanni Battista Contarini, insediato pochi giorni prima, il 28 aprile, negozia l’8 maggio un passaggio di questi contingenti il più possibile indolore per la città. Ci riesce e il transito avviene tra il 9 e l’11 maggio.
Il giorno 11 i francesi, che il 10 hanno sopraffatto a Lodi le ultime resistenze austriache e che ora tallonano le formazioni del Beaulieau, passano il confine veneto alla Benzona e arrivano in prossimità di Crema. Alcune notizie su questo passaggio di Napoleone a Crema si trovano in un manoscritto di Angelo Cerioli, allora parroco di Ombriano. In parte sono state pubblicate da Matteo Benvenuti nell’Archivio Storico Lombardo. Sono state successivamente riprese da Mario Perolini nel suo “Napoleone a Crema” del 1962, ripubblicato nel 1981. Per la comprensione di quei fatti, restano in realtà fondamentali le minuziose relazioni del Contarini al doge Ludovico Giovanni Manin (indicato dal Perolini come Luigi Manin), contenenti la cronaca degli avvenimenti e il significativo resoconto del suo incontro con Napoleone.
Il 12 maggio Napoleone incontra infatti il Contarini, che riesce pure in questo caso a limitare il più possibile i danni, nonostante anche i francesi abbiano già commesso violenze e ruberie attraversando il nostro contado. Napoleone impone il versamento di indennizzi, oltre alla somministrazione di viveri, forniture e mezzi di sostegno per le sue truppe. Sono misure di una notevole gravosità, a cui si riesce comunque a fare fronte. Il Contarini relaziona tempestivamente il doge Manin anche in merito a questi cospicui aggravi economici. Il doge risponde con una lettera elogiativa del comportamento del Contarini. Non bisogna indispettire Napoleone. I francesi passano dunque da Crema e si dirigono verso Cremona. Da questo primo contatto diretto con i francesi, i cremaschi traggono le proprie considerazioni. La nobiltà locale resta in buona parte fedele alla Serenissima. Però qualcuno comincia a pensarla diversamente, tra gli aristocratici e la borghesia cittadina. Nei mesi successivi, alcuni cremaschi comprendono che la loro città fa parte di un corpo istituzionale ammalato, ormai in decomposizione e vicino all’estinzione. Manca, in primis, una forza militare da impiegare in tempi brevi con funzioni di presidio e protezione. Senza questa forza militare di dissuasione, i territori più esposti restano indifesi, gli aggressori spadroneggiano e, alla lunga, la nazione soccombe. La lezione imparata nel maggio 1796, col passaggio di Napoleone in città e con la reazione veneta di accondiscendenza, contribuisce a indurre questi cremaschi, pochi ma determinati, a preparare il terreno per gli eventi, ormai prevedibili, che presto si verificheranno. Quelli del marzo 1797.
La scelta di Venezia di attenersi a una forma di “neutralità disarmata” rispetto alle forze allora in campo risulta del tutto suicida. Il disarmo e l’illusione di una sua reciprocità da parte degli avversari, come sempre nelle vicende umane, si rivela del tutto irresponsabile, soprattutto in frangenti storici e in rapporto a interlocutori di un certo genere. Del resto, anche la “neutralità” veneziana era stata piuttosto discutibile. Il permesso di transito accordato agli austriaci, inseguiti dai francesi, aveva avuto un significato rilevante. E la cosa era stata fatta notare al Contarini nel corso dell’incontro del 12 maggio. Inoltre, molti erano i fuggitivi dalla Lombardia austriaca che trovavano rifugio e conforto in questa parte di terraferma veneta dopo l’armistizio di Cherasco e la battaglia di Lodi, anche a Crema e soprattutto a Bergamo. Si veda il testo di Bortolo Belotti sui nobili milanesi, sulle “vecchie marchese” e sui “giovini signori” che erano arrivati “a frotte”, timorosi di fare la fine dei blasonati francesi. Nel complesso, ci si trova in una condizione caratterizzata da una piena decadenza istituzionale, da una “neutralità” impossibile e da una grave mancanza di armamenti.
In realtà, la Repubblica di Venezia disponeva ancora di forze militari di una certa consistenza, sia su terra che per mare. Basti pensare alla flotta di San Marco. Tuttavia, di tali forze non erano più munite a sufficienza le province lombarde di terraferma. Per lo meno, questa era la situazione di Crema e del suo territorio. A parziale discolpa della Serenissima, va detto che l’armata guidata da Napoleone sarebbe stata comunque un avversario in grado di creare notevoli problemi, anche in caso di opzioni diplomatiche e militari diverse da quelle operate da Venezia. Cosa del resto dimostrata dalle situazioni in cui fu fatta tenace resistenza ai francesi. Almeno, però, si sarebbe evitato quel senso generale di abdicazione e di impotenza che probabilmente ha favorito, almeno in parte, certe prese di posizione filofrancesi nei territori della terraferma lombarda e forse lo stesso rassegnato esito di Campoformio.
Più in generale, avuto riguardo ai territori della Repubblica di Venezia nel loro insieme, le forze militari ancora valide e di qualche consistenza non erano state messe nella condizione di essere opportunamente mobilitate. Si trattava di milizie terrestri non preallarmate, non rese sufficientemente disponibili e quindi non di pronto impiego per un utilizzo di contrasto nei confronti di un’armata agguerrita, motivata e ben condotta come quella francese. Lo stesso atteggiamento generale di passività militare, causato dalla mancanza di scelta di campo e dalla predetta opzione della “neutralità”, portava i vari podestà e i ruoli militari territoriali a non avere una strategia e una sinergia di carattere generale. Una diffusa mancanza di direttive e di piani d’azione coordinati causava comportamenti non sempre adeguati alla gravità di quella situazione. Tutto sommato, si può ritenere che, in questo contesto così difficile, l’azione del nostro Contarini sia stata allora più che positiva e apprezzabile. A Crema, in quell’estremo frangente, così importante, contrariamente a quanto accaduto quasi sempre in passato, era mancata proprio la “casa madre”. Era mancata Venezia. Il resto fu una conseguenza.
La Repubblica di Crema
Torniamo ora al 28 marzo 1797, sugli spalti di Crema, insieme a Fortunato Gambazzocca (il cui cognome a volte, ad esempio nel Benvenuti, è indicato come Gambazzocco e in altri casi come Gambazzocchi). Intorno alle ore dieci del mattino, l’attesa di Fortunato è premiata. Dice il Benvenuti che “fu visto, sulla strada che mena a Treviglio, un corpo d’armati avanzarsi verso Crema: dalla foggia e dal colore delle divise si crederebbero francesi, ma in realtà era un’accozzaglia di legionarj bergamaschi e lodigiani, fra questi alcuni emissarj francesi. Un Vandoni di Vailate capitanava quella legione di trecento e più, i quali approssimatisi a Crema, si divisero in due drappelli, l’uno marciò alla volta di Porta Serio, l’altro verso Porta Ombriano”. L’incontro tra Fortunato, designato da un comitato filofrancese attivo a Milano come il principale responsabile dell’operazione in corso, e la milizia inviata da Bergamo per effettuare il colpo di mano con cui rovesciare le magistrature venete a Crema avviene poco dopo. Il giorno precedente, non a caso, una reparto di cavalleria francese composto da una cinquantina di ussari aveva chiesto al Contarini ospitalità in città e la somministrazione di viveri e foraggi, promettendo di non recar molestia alcuna e assicurando la partenza il giorno dopo per Soncino. Il Contarini cerca di opporsi, poi segue le direttive generali di Venezia sulla acquiescenza verso tali situazioni e acconsente alle richieste dei francesi. I quali restano, nella giornata del 27 marzo, esemplarmente tranquilli. Alle tre di notte arrivano da Venezia al Contarini altre raccomandazioni sul mantenimento della “neutralità”. Il Contarini ormai sa bene che questa parola significa due cose: tolleranza verso i francesi e riduzione al minimo dei loro aggravi e costi.
Non è possibile, per ragioni di spazio, descrivere i singoli momenti e passaggi con cui, nel corso della giornata del 28 marzo, viene formalmente abbattuto il governo della Serenissima in Crema e viene proclamata la Repubblica di Crema (o Repubblica Cremasca). Sia la Storia d’Italia del Benvenuti, sia il suo Dizionario Biografico Cremasco, nella parte riferita a Fortunato Gambazzocca, hanno pagine si sicuro interesse riguardo a quei fatti. Anche le successive vicende di questa Repubblica sono trattate in quei testi in modo significativo e abbastanza equilibrato. Sia la cronaca dei primi giorni di quella nuova istituzione politica, sia gli avvenimenti accaduti nel successivo trimestre della sua vigenza offrono spunti di riflessione ancor oggi degni di considerazione. Il tema è stato comunque oggetto di numerosi testi, prima e dopo quelle due opere del Benvenuti. A tal fine vanno soprattutto tenuti presenti i manoscritti di Luigi Massari e di Giuseppe Racchetti, oltre a quello di Gaetano Severgnini. Diversi altri autori locali hanno successivamente portato il loro contributo in proposito, in tempi più recenti. Esistono ovviamente anche opere a livello non locale che possono lumeggiare determinati aspetti di questa vicenda della Repubblica di Crema. Un esempio è la parte specifica della Storia d’Italia di Carlo Botta, soprattutto in riferimento alla figura e al ruolo di Fortunato Gambazzocca.
Si riportano quindi qui di seguito solo le cose essenziali. Innanzitutto, va sottolineato come trecento miliziani e poche decine di ussari siano stati sufficienti per porre fine, a Crema, al governo della Repubblica di Venezia, dopo un periodo storico di circa tre secoli e mezzo. La città sarebbe stata comunque costretta a far entrare fra le mura quelle bande armate, composte soprattutto da bergamaschi, con i loro emissari francesi. Forse però ciò sarebbe potuto accadere dopo aver opposto almeno una certa resistenza, nonostante la presenza degli ussari in città. Invece le cose sono accelerate dal fatto che questi ussari, entrati in Crema il giorno prima, aprono l’ingresso di Porta Serio, dopo averlo preso sotto il loro controllo. I rivoluzionari entrano quindi in Crema senza colpo ferire. L’ingresso di Porta Ombriano viene lasciato libero dalle scarse forze poste a presidio. A quel punto, le restanti truppe presenti in difesa della città non possono più opporre alcuna resistenza.
Gli invasori prendono possesso del palazzo pretorio, disarmano la guardia e confinano il Contarini, la sua famiglia e gli altri magistrati veneti dentro questo palazzo, in una evidente forma di prigionia. Giovanni Solera riporta che “Zan Battista Contarini”, “ultimo podestà e capitano”, “arrestato con tutta la sua famiglia fu tenuto per qualche tempo in ostaggio”. La situazione in quelle ore è drammatica e potrebbe volgere al peggio. E qui c’è un punto importante da sottolineare in questa nostra vicenda. Sappiamo che a Bergamo e a Brescia, soprattutto a Brescia, le corrispondenti situazioni di presa del potere da parte francese o comunque su incarico francese non erano state semplici come a Crema. E questo anche a prescindere dalle successive gravi “insorgenze” antifrancesi, avvenute soprattutto da parte delle popolazioni valligiane, sia nel territorio bergamasco che in quello bresciano, con i conseguenti scontri armati, le repressioni punitive e le devastazioni. A Crema, i bergamaschi dichiarano di voler portare il Contarini a Bergamo, forse in ceppi, e la soldataglia giunta in città si trova in uno stato di pericolosa agitazione. La cittadinanza cremasca, impaurita, è rinserrata in casa.
Mentre a Bergamo e, ancora di più, a Brescia gli organizzatori locali del golpe sono in un numero cospicuo, appartengono quasi tutti alle oligarchie nobiliari del territorio e possono quindi esercitare un’opportuna interdizione nei confronti dei più facinorosi, che in certi momenti non mancano mai, a Crema invece, in quel momento cruciale, c’è un solo personaggio di spicco, appartenente all’establishment aristocratico cittadino, in grado di moderare i bollenti spiriti e temperare la foga rivoluzionaria. Ed è il nostro Fortunato. Certo, ci sono anche altri che, appartenenti al ceto nobiliare cremasco, partecipano poi, in modo aperto e fattivo, al governo della Repubblica di Crema. Intanto però, quel 28 marzo, lì nel palazzo in cui sono imprigionati il Contarini, la sua famiglia e gli altri magistrati veneti, di non francese e di non bergamasco c’è solo Fortunato. Ebbene, mi sono fatto l’idea che, se l’operazione di passaggio dei poteri è stata così indolore, senza intemperanze ed eccessi in città, senza un colpo d’arma da fuoco o un fendente d’arma bianca contro i reggitori veneti, il merito sia stato soprattutto di Fortunato. Credo che il suo intervento moderatore, in quella sede e in quei momenti, si sia rivelato fondamentale per guidare il difficile passaggio di consegne a livello istituzionale.
Le cose avrebbero potuto andare in modo molto più traumatico e violento. Il Benvenuti, parlando dei nobili attivamente coinvolti in quei rivolgimenti, indica, tra le varie possibili cause della loro presa di posizione, la seguente: “Per non essere travolti dall’onda spaventosa di una rivoluzione democratica, pensarono di farsene essi stessi gl’iniziatori per poterla moderare e dominarvi”. Non sempre questo aspetto rilevante è stato colto da certa nostra cronachistica novecentesca, spesso così dedita all’aneddotica e così propensa al sarcasmo sul ruolo rivoluzionario svolto dall’aristocratico protagonista di quegli eventi. Ammesso e non concesso che si sia trattato di una rivoluzione “da operetta”, cosa di cui comunque si sarebbe potuto prendere atto solo a cose compiute, dovrebbe far riflettere il fatto che è stato in quel caso meritorio aver saputo gestire una rivoluzione in modo indolore e non nel sangue.
Come si è detto, pochi giorni prima, in modo meno agevole e spedito che a Crema, sempre in esecuzione delle indicazioni del comitato filofrancese di Milano, dei colpi di mano simili erano avvenuti a Bergamo (il 12 marzo) e a Brescia (il 18 marzo). In queste città, soprattutto a Brescia, il putsch aveva avuto dinamiche più complesse. Si era trattato di vicende alquanto diverse rispetto a quella cremasca, anche se la logica di tutte queste operazioni era stata la stessa: evitare in queste tre città di dover arrivare a una presa del potere troppo scoperta e forse violenta da parte francese; puntare su esponenti locali di rango per creare entità istituzionali filofrancesi ma formalmente indipendenti; accelerare in tal modo i successivi passaggi politici, diplomatici e militari per la complessiva e definitiva cessazione della Repubblica di Venezia. Con la creazione di queste tre “Repubbliche Sorelle” della Repubblica Francese, cessa quindi il governo veneziano nelle tre province lombarde poste in terraferma. Si tratta di tre veri e propri “governi provvisori”. Nel caso di Brescia, la cosa è del tutto esplicita.
La tematica del governo provvisorio è molto interessante, sia dal punto di vista della storia delle istituzioni politiche, sia da quello più rigorosamente giuridico. Per quanto riguarda il governo provvisorio instaurato in occasione della proclamazione della Repubblica di Crema, governo che poi dura tre mesi, fino all’ingresso del nostro territorio nella Repubblica Cisalpina, piuttosto scarso è stato sinora l’interesse manifestato nei confronti della sua valenza politico-istituzionale. Quasi del tutto nullo l’interesse riferito ai suoi profili giuridici. Manca infatti, per la Repubblica di Crema, uno studio riferito agli elementi caratteristici identificati dalla dottrina in ambito giuridico sul tema dei governi provvisori. La breve durata e la tutela francese non sarebbero d’impedimento. Va detto che, a parte l’epoca comunale, nella quale peraltro i tuziorismi imperiali e in parte cremonesi non possono essere ignorati, il breve periodo della signoria dei Benzoni e questa Repubblica di Crema rappresentano, nonostante gli innegabili condizionamenti rispettivamente viscontei e francesi, gli unici due momenti, in tutta la nostra storia cremasca, di “indipendenza”, per lo meno in senso formale.
La cospirazione
Come era stata organizzata, da parte francese, l’operazione di smantellamento dei poteri veneziani in questa parte lombarda della terraferma? E come si trovò coinvolto, in tale progetto, il nostro Fortunato? Dice il Benvenuti che Napoleone, dopo aver preso possesso del Piemonte e della Lombardia austriaca, “ordì delle trame” contro la Repubblica di Venezia, “per sovvertirne gli Stati e compiere così più facilmente il vagheggiato disegno di annichilirla. Per opera sua creossi in Milano una congregazione segreta il cui fine era di suscitare rivoluzioni nelle terre dei Veneziani; vi partecipavano i repubblicani di Lombardia, alcuni Francesi, e molti nobili delle province venete, tra i quali i Lecchi, i Gambara, i Beccalosi, i Fenaroli di Brescia; gli Adelasio, gli Alessandri, i Caleppio di Bergamo, ed il marchese Fortunato Gambazzocco di Crema. A quella società presiedeva certo Landrieux, capo dello stato maggiore della cavalleria. Il marchese Gambazzocco, fautore caldissimo dei repubblicani francesi, maneggiavasi a Crema occultamente onde spargere tra i cittadini il fuoco rivoluzionario”. Seguono alcune notazioni sulle difficoltà incontrate da Fortunato nel trovare associati alla causa filofrancese; sulla tipologia dei soggetti che comunque aderiscono all’operazione di creazione di un’istituzione repubblicana a Crema; sulle differenti motivazioni di questi soggetti entrati nel progetto.
Fortunato partecipa attivamente alle riunioni del comitato segreto milanese. È chiaramente riconosciuto in quel contesto come il responsabile dell’operazione per quanto riguarda Crema e la provincia cremasca. Dissimula a Crema la sua azione di propaganda e proselitismo in un modo che a qualche nostro autore locale è parso aneddoticamente gustoso. In realtà, Fortunato trova per la sua azione cospiratrice una copertura molto indovinata nei confronti degli organi di polizia della Serenissima. Utilizza infatti per questo la casa del conte Luigi Tadini, dove è cavalier servente della signora contessa. L’istituto del cavalier servente, anche a Crema, ha avuto ed ancora aveva a quel tempo diverse, diciamo così, declinazioni operative. Non sappiamo di preciso quali fossero gli effettivi rapporti di Fortunato, già oltre la quarantina, con la sua quasi coetanea Libera Moronati, contessa di Salizzole, sposata dal Tadini nel 1773. Sappiamo comunque dal Benvenuti che “il generoso conte soleva aprire le sue sale a conversazioni, a pranzi, a divertimenti. Quindi l’occhiuta Polizia della Veneta Repubblica poteva illudersi facilmente, supponendo che il Gambazzocco frequentasse quella casa per ispassarsela, come usavano i nobili d’allora, banchettando, giocando e facendo all’amore con la moglie altrui”. Il Benvenuti corregge nel Dizionario Biografico Cremasco l’errore in cui era incorso nella Storia di Crema, dove aveva asserito che Fortunato fosse spesso ospite come cavalier servente non in casa Tadini ma in casa Monticelli, dove “serviva l’avvenente padrona”.
Il Tadini è il noto personaggio (padre di Faustino, la cui scomparsa è commemorata dalla Stele del Canova) della celebre collezione d’arte, delle polemiche per la Storia di Bartolomeo Bettoni e della fondazione dell’Accademia Tadini a Lovere. È anche uno dei più attivi partecipanti alle vicende della Repubblica di Crema, nonostante le ritrattazioni da lui compiute dopo la Restaurazione. Riguardo al Bettoni, il Libro settimo della sua Storia, trattando delle “Ultime Rivoluzioni 1790-1816”, supera ogni altra parte dell’opera in contumelie antifrancesi e piaggerie filoaustriache. È palese l’influenza del contesto storico austriacante della Restaurazione. È palese il progetto editoriale adulatorio del committente del Bettoni, il suo protettore Luigi Tadini. È palese l’intento di captatio benevolentiae del Tadini verso Francesco I (si veda anche il suo saluto di benvenuto per la visita dell’imperatore a Crema nel febbraio 1816). È insomma palesissima l’operazione di allineamento storiografico del Bettoni ai rinnegamenti politici del Tadini, già a capo della guardia nazionale repubblicana e trasformatosi, dopo il ritorno al potere dei goghi, in zelatore delle istanze reazionarie filoimperiali cremasche e lombardo-venete. Vale quindi quanto dettone dal Benvenuti nel Dizionario Biografico Cremasco.
Non ci sono dubbi sulle difficoltà incontrate da Fortunato nel convincere gli esponenti dell’aristocrazia cremasca ad aderire all’operazione di passaggio di poteri di cui era l’artefice responsabile. Tuttavia, va anche detto che, lo stesso 28 marzo 1797, a poche ore dalla destituzione delle autorità venete, già viene definito un governo della Repubblica di Crema con attribuzioni divise in sei comitati principali, coadiuvati da sei corrispondenti comitati supplenti. E subito alcuni membri del ceto nobiliare cittadino, appartenenti in alcuni casi a famiglie di notevole rilevanza, vengono ufficialmente nominati in questi organi di governo locale. È evidente come, con quasi tutti questi componenti, già in precedenza fossero intercorsi contatti, concertazioni e accordi sui ruoli da ricoprire e sui programmi da realizzare. Insomma, Fortunato tesse il suo sistema di relazioni e prepara i nuovi assetti amministrativi locali in modo ordinato e preciso. L’idea di un governo locale improvvisato ed estemporaneo, dal quale l’aristocrazia cremasca si dissocia in modo quasi totale appare più come una modalità narrativa che come un dato di fatto storico.
Il momento più difficile, nel quale Fortunato è il solo nobile cremasco in mezzo agli emissari francesi e ai miliziani bergamaschi appena entrati in città, si risolve in poche ore e, come si è detto, nel modo migliore. In quelle ore, Fortunato aveva gestito la situazione col Lhermite, che era il principale emissario francese, con il capitano francese Bettenac, l’altro capitano francese Garuf entrato in Crema coi suoi ussari il giorno prima, il Vandoni di Vailate già nominato, alcuni capi delle truppe che avevano preso possesso della città, come un Longaretti, un Asperti, un Locatelli, un Tomini, tutti bergamaschi. Una volta impostata la situazione nel modo progettato, ecco che si manifestano i congiurati suoi alleati, i cospiratori rimasti sino ad allora nell’ombra. Nel comitato principale, quello di difesa generale, Fortunato entra insieme ad Agostino Benvenuti. Carlo Monticelli e Silvio Zurla sono nel comitato supplente. Nel comitato di organizzazione militare vanno in carica Luigi Vimercati e Giovanni Battista Guarini. Francesco Martini e Roberto Vimercati Sanseverino sono in quello supplente.
Negli altri comitati, principali e supplenti, spiccano i nomi di altri nobili, di esponenti della borghesia, di rappresentanti delle professioni. Sono i comitati di polizia, delle finanze, del commercio, della sanità e vettovaglie. Camillo Zurla è capo della struttura di supporto dei segretari, mentre tra i segretari supplenti ci sono Lorenzo Giavarina e Antonio Oldi. Nei giorni successivi l’ordine è ripristinato, i miliziani venuti da Bergamo vengono congedati, la popolazione viene rassicurata e partecipa con notevole coinvolgimento alle cerimonie pubbliche indette dalla nuova Repubblica, come quelle organizzate intorno agli alberi della libertà. Luigi Tadini è nominato comandante della guardia nazionale. Altri nobili, come Orazio Bonzi, partecipano attivamente alle funzioni del nuovo governo. Il Bonzi propone persino di innalzare in piazza una ghigliottina. Ma lui e la sua consorteria radicale, definita dal popolo Compagnia Brusca, sono ricondotti a più miti consigli da Fortunato e dagli altri membri del governo. Viene soppresso l’ufficio dell’inquisizione dei frati domenicani. Si costituisce un Circolo costituzionale e Luigi Massari ne viene eletto segretario. Il Massari sarà poi nel gennaio 1799, un anno e mezzo dopo l’ingresso nella Repubblica Cisalpina e pochi mesi prima del ritorno degli austro-russi, presidente della nuova municipalità cremasca, riformata e contenuta in sei membri. Ma cosa ne è del Contarini, della sua famiglia, degli altri reggitori veneti?
Come si è detto, ogni tentativo, da parte delle milizie bergamasche, di tradurre il Contarini a Bergamo viene subito bloccato da Fortunato. Successivamente, raggiunto in separata sede un accordo col Lhermite su come procedere, Fortunato organizza l’uscita da Crema del Contarini e degli altri ostaggi. Consiglia al Contarini di non presentarsi in pubblico, di non ricevere altre visite e di prepararsi alla partenza insieme a coloro che con lui sarebbero stati fatti uscire incolumi dalla città, per poter poi riparare a Venezia. Alla mezzanotte del 29 marzo, Fortunato e il Bettenac, scortati da alcune guardie e con molta circospezione, li conducono tutti fuori da Porta Serio, dove quattro carrozze sono in attesa. Vi si fanno salire il Contarini, i suoi familiari e i magistrati e ufficiali veneti. I postiglioni sono incaricati di portarli fuori dalle zone del cremasco e del bresciano e condurre poi le carrozze a Venezia. Con la partenza dell’incolume Contarini, la cospirazione può dirsi perfettamente riuscita.
L’ultimo marchese Gambazzocca
Sulla data di nascita di Fortunato non forniscono indicazioni precise né il Benvenuti, né il Racchetti, né i pochi altri ricercatori che sinora hanno indagato su questo personaggio. Sappiamo, da alcuni elementi concordanti, che dovrebbe essere nato alla metà del Settecento. Il Perolini dà nel tempo due versioni diverse. Nel suo libro sui palazzi storici di Crema, riedito nel 1995, afferma che “dagli stati d’anime della parrocchia di S. Giacomo si apprende soltanto che egli nacque intorno al 1752 e le ricerche estese a Moscazzano, dove i Gambazzocca tenevano possedimenti ed una villa (oggi Marazzi) hanno dato esito negativo”. Invece, in un altro suo testo soltanto dattiloscritto, che era presente anni addietro presso la biblioteca di Crema, fornisce un’indicazione diversa, dicendo che “nacque in Moscazzano il 15 marzo 1750. Nei registri di nascita di questa parrocchia è segnato Lodovico e non Fortunato”. Siccome i genitori avevano avuto solo due figli, arguisce il Perolini, questo Lodovico è in realtà Fortunato, “al quale fu apposto forse dalla famiglia un secondo nome”. Questo autore indica come primo figlio il Lodovico-Fortunato e come secondo figlio Ottone, mentre nelle genealogie del Racchetti, in genere molto attendibili, Ottone è il primogenito dei due fratelli. Non è dato sapere se il Perolini abbia consultato in proposito la famiglia Marazzi, che conserva dei Gambazzocca mappe e documenti. Non forniscono indicazioni in proposito né Giorgio Zucchelli, nella sua opera sulle ville cremasche, né Filippo Selis, che nel suo libro del 2006 su Moscazzano tratta anche dei possedimenti Gambazzocca. Si può quindi dire che la ricerca della data di nascita di Fortunato sia ancora in corso.
La famiglia Gambazzocca era tra le più antiche, per risalenza storica e attestata nobiltà, tra le cremasche. La tradizione familiare vantava origine romana e riteneva che gli avi si fossero rifugiati nei territori lombardi quando Totila, durante le guerre gotiche, conquistò Roma alla metà del VI secolo. Di certo la famiglia comincia a essere documentata storicamente a Crema quando nel 1185 Federico I investe i cremaschi dei diritti feudali che tenevano i conti di Camisano e di altri privilegi imperiali. Uno dei quattro rappresentanti che sottoscrivono quell’atto a nome del popolo cremasco è un Ottone di questa stirpe. Due anni dopo, nel 1187, reggendosi la città con forme repubblicane, ne è console un Ambrogio di questa famiglia. I Gambazzocca prosperano e hanno poi rango di nobiltà per il ruolo svolto nelle cariche e nei consigli cittadini. Essendo ghibellini, patiscono al tempo dei guelfi Benzoni, pur continuando a crescere in potere e in beni nel nostro territorio. Il 30 aprile 1700, i Gambazzocca conseguono dall’imperatore Leopoldo I il titolo di marchesi, conti e cavalieri dell’impero, soprattutto per precedenti meriti militari. Il bisnonno di Fortunato, Carlo, fu un valente avvocato, come ricorda Giovanni Battista Cogrossi, ed è il primo munito di titolo marchionale. Suo figlio Ottone è provveditore di Crema nel 1692 e nel 1711. Il padre di Fortunato, Nicolino, è colonnello della Serenissima e governatore di Orzinuovi. La famiglia si riduce a questo ramo discendente da Carlo, con Ottone, che sposa Giulia Zurla e muore nel 1738, e poi Nicolino, che sposa Marianna Lascari e muore nel 1760. I soli due figli di Nicolino, Ottone e Fortunato, sono gli ultimi due rappresentanti maschi della famiglia Gambazzocca. Infatti, i due figli maschi di Ottone muoiono entrambi “fanciulli”. Delle sei figlie di Ottone si farà cenno più avanti. Fortunato resta celibe e non ha figli, per lo meno legittimi o noti.
Le notizie sulla vita di Fortunato prima delle vicende sopra riportate sono molto scarse e frammentarie. Bernardo Nicola Zucchi ce ne avrebbe probabilmente fornite, ma i suoi scritti terminano negli anni della nascita di Fortunato. Giovanni Battista Terni lo cita in alcuni passaggi delle sue Memorie, riportando la sua partecipazione a feste ed eventi teatrali, anche in collegamento col fratello Ottone e col Tadini, di cui il Terni rammenta in più punti la moglie e il suo cavalier servente, per l’appunto Fortunato. Lo stesso autore si diffonde non poco sulla vicenda di cui è protagonista nel 1781, dicendo che “nel primo giorno d’agosto nacque in Crema un caso orendo, che riempì tutti di spavento e di bile”. L’occasione è una partita col pallone, “che in ora si giuoca tutti gli anni”. Non conosciamo le regole del gioco, che era praticato in città dai nobili, con gran gusto e con ammirazione per chi aveva “una bella battuta”. Tra i molti che assistono al gioco, ci sono Fortunato, alcuni altri nobili, Faustino Vimercati Sanseverino, che “corbella sempre col suo dire gli amici” e un “tenente de’ Croatti a cavallo”. Ne nasce un alterco, probabilmente per la lingua lunga di Faustino, e il tenente reagisce. Fortunato interviene in modo, diciamo così, piuttosto assertivo e l’ufficiale veneto se la prende con lui.
Si riporta, per maggiore brevità, la sintesi fatta dell’episodio dal Racchetti nelle sue genealogie: “Assalito in piazza da un Ufficiale Veneto, non solo valse di difendersi, ma lo disarmò”. In pratica, si incrociano le spade e Fortunato ha la meglio. “Trovandosi il codardo scornato, ordinò a parecchi soldati colà presenti, d’ucciderlo, ma lesto egli, facendogli spalla un cagnotto, riuscì, sebene ferito entrare in una bottega e rinchiudervisi”. La vicenda ha poi un seguito abbastanza avventuroso e testimonia come anche a Crema l’aristocrazia si divertisse spesso e volentieri in svaghi e giochi, mettesse di frequente mano alla spada, ne nascessero ferimenti e a volte uccisioni per puntiglio d’onore e non mancassero litigi e duelli coi militari di presidio. Fortunato sembra aduso a baruffe e scontri con le armi in pugno. Aggiunge infatti il Racchetti che varie avventure del genere “gli occorsero, specialmente nella sua gioventù”. Insomma, si tratta di un personaggio che, dal quel poco tramandatoci, aveva un certo carattere.
La scelta di non sposarsi e non avere figli consente a Fortunato una piena libertà, da tutti i punti di vista. Ha rendite cospicue e può quindi concedersi viaggi, piaceri e avventure di sicura soddisfazione. Mentre il fratello Ottone si sposa due volte ed ha almeno otto figli, Fortunato ha una giovinezza molto libera e scevra da ogni condizionamento familiare. Anche i pochi riferimenti del Terni al suo coinvolgimento nelle feste, nei carnevali e in certe rappresentazioni teatrali in città favoriscono l’idea di un’esistenza serena e spensierata. La sua vita sembra in parte cambiare una volta giunto sulla quarantina. Fortunato inizia allora ad assumere incarichi pubblici e a partecipare maggiormente, oltre che alla vita mondana e galante, anche ad alcuni impegni istituzionali. Non conosciamo le ragioni di questo parziale mutamento di abitudini. Sappiamo però che il 31 luglio 1791 muore il fratello Ottone. Il decesso avviene nella parrocchia di San Giacomo e Ottone viene sepolto in San Pietro Martire, oggi San Domenico. Nel 1791 Fortunato diviene uno dei tre provveditori di Crema. Il 31 maggio 1793 viene nominato tra gli amministratori di un’istituzione molto importante per la nostra città, l’Ospedale degli infermi di Porta Ripalta. Succede in questa carica allo zio Giovanni Battista. Fortunato inizia quindi a esercitare un ruolo politico in ambito cittadino. E trasfonde in questa nuova passione civile alcune doti del suo carattere, come il coraggio di prendere le iniziative necessarie ma anche la capacità di gestire le situazioni, quando è opportuno, con moderazione e prudenza. Dice infatti il Racchetti che “egli era destro ed ardito, intrepido nelle sorprese, e pronto a’ ripieghi”.
Si è detto quale ruolo abbia avuto Fortunato negli avvenimenti che hanno portato alla Repubblica di Crema nel 1797. Una volta condotta a termine questa operazione istituzionale, mantiene ancora incarichi nel governo provvisorio che ne deriva e poi nella municipalità di Crema dopo il passaggio del nostro territorio alla Repubblica Cisalpina alla fine di giugno del 1797, passaggio ufficialmente ratificato nell’ottobre successivo col trattato di Campoformio. Poi Fortunato, forse pago del risultato raggiunto, sembra lasciar posto ad altri soggetti nell’ambito delle nuove magistrature cittadine. Tra questi, avrà poi un ruolo rilevante il Massari. Quando gli austro-russi tornano a occupare i territori italiani e quindi anche la città di Crema, tra l’aprile 1799 e il giugno 1800, Fortunato resta prudentemente nell’ombra, per evitare vendette e ritorsioni. Dopo la seconda campagna d’Italia di Napoleone e la vittoria francese a Marengo del 14 giugno 1800, il ripristino dei poteri della Repubblica Cisalpina ristabilisce anche a Crema questa realtà politica, che dura fino alla proclamazione della Repubblica Italiana nel gennaio 1802, seguita poi dal Regno d’Italia nel marzo 1805. Fortunato viene nominato da Napoleone, nel 1802 a Lione, membro del Corpo Legislativo della nuova Repubblica Italiana. Riceve anche altri incarichi molto rilevanti, come quello di componente della Consulta Straordinaria. È nominato membro del Collegio Elettorale dei Possidenti. Non solo a Crema ma anche a Milano, dove ha da tempo una sua residenza, Fortunato gode di una generale estimazione.
Nella prima decade dell’Ottocento, di lui pare si perdano le tracce. Il Benvenuti afferma che “dei conseguiti onori non poté godere lungamente: morte lo colse”. Il Racchetti si limita a dire che “morì dopo cominciato il secolo XIX”. Il Perolini, nel citato libro riedito nel 1995, dice che “egli appare nello stato d’anime di San Giacomo del 1804 (corso Porta Ripalta civ. 636) e poi più”. Aggiunge che “molto probabilmente decedette a Milano ove il Gambazzocca aveva fissato il domicilio secondo un elenco di contribuenti datato 18 Nevoso anno X Rep. (7 gennaio 1802) conservato nell’A.S.C., parte 2ª, cart. 2/11”. Nel suo altro citato testo dattiloscritto, dice che “ignorasi l’anno di sua morte, né alcuna notizia si rinvenne in proposito negli archivi parrocchiali di S. Giacomo, di S. Benedetto e del Duomo di Crema, né in quello di Moscazzano. L’ultimo atto, che di lui si conserva nella famiglia Fadini, è del 1803”. Filippo Selis, nel suo libro su Moscazzano, riferisce che l’attuale Cascina Groppelli di Moscazzano “è stata edificata in sede di una struttura precedente, denominata podere Malcantone. Il podere è citato nel testamento di Fortunato Gambazzocca, nel quale si legge che la proprietà venne assegnata nel 1805 alla nipote Caterina”, figlia di Ottone e moglie di Antonio Marazzi. Trattando invece dell’attuale Villa Groppelli, il Selis dice che questa proprietà passa alla nipote Eugenia, figlia di Ottone e moglie di Giuseppe Araciel, sempre in forza dello stesso testamento, aggiungendo in nota che questo “passaggio di proprietà è documentato tramite testamento del 10 dicembre 1805 e del 6 aprile 1809 con roganti Ternagni e Averara”.
Quindi, non solo la data precisa di nascita di Fortunato resta ancora da scoprire ma anche la sua data di morte non è stata ancora identificata, per lo meno da quanto sinora rilevato dalle fonti consultate. La scomparsa del suo nominativo da ogni registro lascerebbe supporre un decesso avvenuto tra il 1805 e il 1806, se non fosse per il cenno del Selis sul 1809. Però è una mera ipotesi, senza alcun riscontro documentale effettivo. Probabilmente, sia per la data di nascita, sia per quella di morte, come per altre informazioni non ancora accertate sulla figura di Fortunato, potrebbero essere d’aiuto gli archivi della famiglia Marazzi.
Un’importante eredità
Quando un’importante casata si estingue, l’eredità più considerevole è quella storica, con le gesta, i fasti e i meriti di quella stirpe. È un’eredità immateriale, costituita dagli onori e dai valori che per secoli la famiglia ha saputo rappresentare, per i propri membri ma anche per la collettività di cui ha fatto parte. Poi ci sono altri elementi ereditari più materiali, in genere palazzi di città, ville di campagna, notevoli possedimenti, allora soprattutto fondiari, e vari altri diritti su beni urbani e rurali. “I Gambazzocca avevano concentrato tutti i loro possedimenti rurali nel territorio di Moscazzano, costituendo in quel paese una sorta di feudo”, dice lo Zucchelli. “Vi si erano insediati certamente già dalla prima metà del secolo XIV”. Questo autore indica poi gli immobili in centro paese, i poderi, le cascine e gli estesi fondi agricoli in loro proprietà, quantificando in circa 2.500 pertiche l’estensione dei loro fondi in questo Comune. Il santuario della Madonna dei Prati fungeva da cappella di famiglia.
Il Selis dà conto delle vicende dei complessi immobiliari già dei Gambazzocca, come le attuali Villa Marazzi, Villa Albergoni e Villa Groppelli, la già citata Cascina Groppelli e l’attuale Cascina Ginelli alle Colombare. Per le relative vicende successorie, si rinvia ai testi dello Zucchelli e del Selis. Si è fatta menzione di questi beni in quanto indicati nel citato testamento di Fortunato del 1805. In Crema i Gambazzocca avevano diverse proprietà immobiliari. La principale era quella in corso di Porta Ripalta, oggi via Matteotti, ampliata nel tempo con progressivi ingrandimenti. La parte familiare originaria era quella davanti alla chiesa di San Giovanni Battista. Nel 1706 i Benvenuti avevano ceduto a Ottone e Venturino Gambazzocca, figli di Carlo, la parte adiacente, fino al canton di San Domenico, oggi via Verdelli. La profondità di questa proprietà immobiliare era notevole, confinando a ponente col convento di San Domenico. Fortunato abitava in questo palazzo, come anche il fratello Ottone con la sua famiglia. Come era abitudine per le famiglie aristocratiche, all’epoca ma anche in tempi più recenti, i soggiorni in città si alternavano a quelli nelle ville di campagna, soprattutto nella stagione estiva.
Ottone, che come si è detto muore nel 1791, ha in prima moglie Aurelia Oldi, da cui ha un maschio, Nicola Giuseppe, che “morì fanciullo”, e cinque femmine: Isabella, che pure “morì fanciulla”, Lucrezia, Maria Caterina, Teresa Adelaide e Teresa Fortunata. Dalla seconda moglie, Adelaide Azzati, lodigiana, ha un maschio, Giovanni Battista, che pure “morì fanciullo”, e una femmina, Eugenia Maria Carolina. Si segue in questo il Racchetti, nelle sue genealogie. Tre delle figlie superstiti di Ottone, Lucrezia, Marianna Fortunata e Teresa Adelaide, diventano monache nel convento di Santa Monica. Dopo la chiusura dei conventi e il congedo delle suore che vi dimoravano, tornano in famiglia, fino alla loro morte. Il Perolini non tiene conto del Racchetti e dice che le figlie monache di Ottone non erano tre ma due. Afferma inoltre che erano entrate nel convento di Santa Maria Mater Domini, l’attuale complesso dei cosiddetti Stalloni, e non in quello di Santa Monica. Maria Caterina, figlia della Oldi, ed Eugenia Maria Carolina, figlia della Azzati, si sposano. Dopo la scomparsa di Fortunato, da loro due passano tutti i beni del patrimonio, a favore delle famiglie dei rispettivi mariti.
Parte dei beni Gambazzocca, a Moscazzano e altrove, attraverso Eugenia Maria Carolina, passa alla famiglia Araciel. Eugenia sposa infatti Giuseppe Araciel (Ruitz de Araciel), marchese di Cerro, di antica famiglia spagnola trasferitasi a Milano alla metà del Seicento. La maggior parte dei beni Gambazzocca, a Crema e a Moscazzano, passa invece ai conti Marazzi. Maria Caterina sposa l’avvocato Antonio Marazzi nel 1785. Muore nel 1817. Antonio muore nel 1822. Gran parte delle proprietà di Moscazzano, compresa la Villa padronale, che è per lo Zucchelli “la più prestigiosa delle ville di famiglia”, passa poi al figlio Vincenzo, quindi al nipote Paolo e ai successivi discendenti del ramo di Antonio (Lodovico, Alessandro e l’attuale proprietario, Lodovico). Ai Marazzi passa anche il palazzo di Crema. Antonio e Maria Caterina vi entrano nel 1806. E ciò avvalorerebbe il 1805 o il 1806 come data di morte di Fortunato, pur ponendo un problema di correlazione con l’altra data del 1809 indicata dal Selis per il testamento. Se l’ultimo marchese della casata è stato Fortunato, va detto che in questo palazzo muore l’ultima persona col cognome Gambazzocca. Si tratta di Teresa Adelaide (riportata dal Perolini come Teresa Maria), che è una delle tre monache figlie di Ottone, rientrata in famiglia dopo la soppressione del convento. I Marazzi la lasciano vivere qui fino a quando si spegne, il 27 febbraio 1858, all’età di 84 anni. Secondo il Perolini, l’ultima Marazzi ad abitare questo palazzo è Caterina, vedova di Orazio Fadini, che viene a mancare il 2 novembre 1883. Riferisce il Perolini che “lo stabile venne poi acquistato dal dott. Filippo Zambellini (cui è intestata una via) che nell’agosto del 1910 lo rivendette al Credito Commerciale”.
Anche il nome Fortunato passa dai Gambazzocca ai Marazzi. Portano infatti questo nome il celebre generale e uomo politico Fortunato Marazzi, un suo nipote e, oggi, un suo trisnipote.
Per l’aiuto fornito in queste ricerche, si ringraziano gli addetti alla Biblioteca di Crema e i volontari dell’Archivio Diocesano di Crema, in particolare il signor Mario Gnesi.
Nelle due immagini, il frontespizio e il testo completo della lettera con cui Fortunato Gambazzocca intima al parroco di Montodine di rimuovere dalla chiesa i blasoni e le iscrizioni contenenti i titoli nobiliari.
© RIPRODUZIONE RISERVATA




















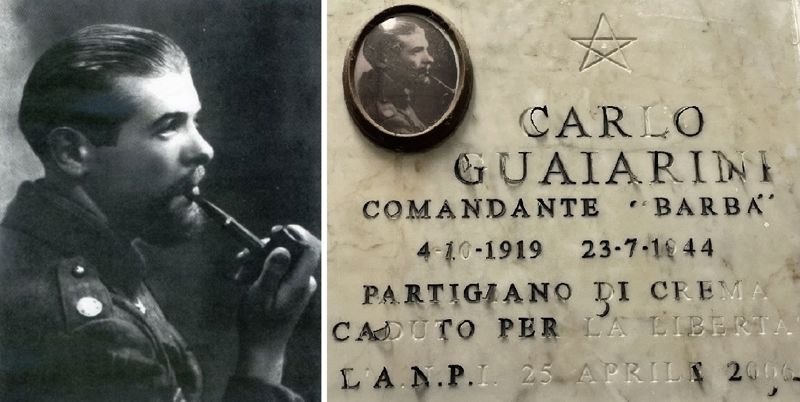

























commenti