Le pietre raccontano. Nella strettoia tra Battistero e Camposanto dei Canonici le scritte dei condannati a morte in attesa della esecuzione, le date, le invettive contro le autorità
Le pietre cittadine ci osservano mute attraverso i secoli, portando solennemente i segni del tempo, fredde nella nebbia invernale o roventi sotto il solleone estivo. Se interrogate con pazienza analitica, per un occhio attento e curioso esse rappresentano una miniera di informazioni in grado di spalancare tanto inusitate quanto vive finestre sul passato storico.
Alcuni di questi segni sulla pietra si trovano ad esempio nella strettoia compresa tra il Battistero e l’edificio soprastante il Camposanto dei Canonici (detto anche Scarsella o Cappella di San Giovanni): proprio qui vi era qui uno spazio nel quale venivano rinchiusi i condannati a morte: secondo alcuni era la parte ora mancante che annetteva la Scarsella al Battistero (demolita nel ‘500), mentre secondo altri si trattava di una gabbia che comprendeva la strettoia sopra detta e lo spazio immediatamente antistante questa dalla parte di piazza Zaccaria, quando il collegamento era già stato demolito. In ogni caso qui si dice venissero collocati i condannati a morte, in attesa di essere trasferiti nella cappella di S. Gerolamo dove passavano in preghiera l’ultima notte prima dell’esecuzione (segnalata dal lugubre suono della campana del palazzo Comunale la sera precedente, all’una di notte e all’alba). La parte che univa il Battistero all’attuale Cappella venne demolita verso la metà del XVI secolo (il Puerari spiega che se ne decurtarono ben sei braccia «per liberar il battistero d’intorno»); e nessuna traccia rimane di un’eventuale gabbia posizionata successivamente. Ma una testimonianza sembra comunque essere rimasta: essa si trova sulle pietre alla base dei lati nord e nord-est del Battistero (quindi dalla parte di Piazza Zaccaria, ex Forum Piscarium) dove, per intendersi, sono incisi anche le misure del mattone e della tegola cremonese. Osservando i mattoni su quel lato dell’ottagono, vi si notano incise delle scritte: ebbene, esse sono quelle lasciate nei secoli dai condannati a morte che internati in quel budello negli ultimi giorni prima del patibolo. Tra quella ancora leggibili (altre sono irrimediabilmente sbiadite) vi sono semplici iniziali e firme per esteso assieme a numerose date (in una si legge chiaramente «1794», in un’altra «morto 17 agosto», in altre ancora le date arrivano addirittura al 1300 e più indietro); contemporaneamente, vi si riconoscono anche alcune pesanti invettive alle autorità cittadine laiche e religiose: «cristalli di parole, l’ultima bestemmia detta», per dirla con La ballata degli impiccati di Fabrizio de Andrè.
Prima di essere internati dietro il Battistero pochi giorni prima dell’esecuzione, la detenzione si teneva comunque nelle carceri. Fra ili XIII e il XIX secolo più fonti posizionano le prigioni dentro palazzo Comunale, nell’ala compresa tra le attuali piazza Pace, via Lombardini e piazza Stradivari (detta in passato appunto “La Guardiola”, mentre al piano superiore erano l’alloggio del Giudice e il Tribunale e, a fianco, la Torre dei Condannati – quella che attualmente dà su piazza Pace).
Le esecuzioni capitali rappresentano una caratteristica costante della storia di Cremona (come del resto di ogni altra città) almeno sino alla metà del XIX secolo. Nell’anno 1247 della sua Cronica, il francescano di Parma Salimbene de Adam riferisce della sommaria esecuzione capitale di alcuni milites della Marca Anconetana nei pressi del bastione di Porta Mosa, tenuti in ostaggio in città per volere di Federico II di Svevia. «L’imperatore – annota il monaco – faceva tenere in ostaggio alcuni cavalieri della Marca Anconetana nella città di Cremona: alcuni in carcere, altri sotto custodia in alcune abitazioni. Proprio su coloro che versavano in condizione di libertà vigilata pendeva un un destino funesto, senza che essi ne avessero alcun sospetto. Giunse infatti un messo imperiale alle case di quei cavalieri marchigiani, mentre si apprestavano a lavarsi prima della cena, ordinando loro di montare immediatamente a cavallo e senza indugio seguirlo sin dall’Imperatore. Ma, giunti ad un terreno aperto situato appena fuori delle mura di Cremona e chiamato Mosa (qui est extra civitatem Cremonae et appellatur Mosa), il messo li condusse ad un patibolo dove furono impiccati. E i carnefici dicevano: “così vuole l’Imperatore per voi traditori”. […] Il giorno seguente si recarono ivi i Frati Minori per deporli dalla forca e seppellirli, e a stento riuscirono a tener lontani i lupi per evitare che li divorassero mentre ancora pendevano dal patibolo (et vix potuerunt lupos abigere ne comederent eos, dum adhuc in patibulis dependerent). Vidi tutto ciò con i miei occhi perché all’epoca vivevo a Cremona (haec omnia vidi quia in Cremonae habitabam tunc temporis)”.
Sempre dalle pagine di Salimbene apprendiamo della triste vita che conducevano i prigionieri nelle tetre carceri comunali cremonesi del Duecento e delle torture cui spesso erano sottoposti. Nell’anno 1250, in occasione della cattura di alcuni soldati presso il fiume Taro, il dotto monaco riferisce: «li condussero a Cremona in ceppi e li gettarono in carcere. Sia per costringerli a redimersi sia per vendetta, si divertirono compiendo cruenti oltraggi su quei detenuti: e, nelle carceri, li appendevano per i piedi o per le mani (suspendebant eos in carceribus per manus et per pedes), strappavano loro i denti in maniera disumana (extrahebant eis dentes terribili et horribili modo), e ficcavano loro in bocca dei rospi (bufones ponebant in ore ipsorum)”; in quel tempo vi erano addirittura alcuni incaricati di inventare nuovi supplizi”.
Sorvegliate da un Capitano e da alcune guardie, le prigioni contavano diversi locali, descritti dai documenti come angusti, bui e maleodoranti, dove spesso si tardava a cambiare la paglia della lettiera, costringendo i condannati a vivere tra fetidi miasmi (con episodi, non infrequenti, di morti avvenute prima dell’esecuzione per le malattie contratte in quelle segrete). L’ingresso era situato sul lato sud-est di piazza Stradivari (all’incirca dove ora si trovano gli uffici di Spazio Comune), sormontato da un porticato con una trave alla quale venivano appesi i detenuti durante le torture. Sino al XVI secolo circa, le esecuzioni si tenevano davanti alla chiesa di S. Erasmo (ora non più esistente) nella contrada che ancora oggi porta quel nome, situata in fondo a via Palio dell’Oca. Ma il “miglio verde” per giungervi era ben più lungo di quello dell’omonimo film. Essi raggiungevano la forca in una pittoresca processione formata da tutti i paratici di arti e mestieri, tutti i tribunali, i dicasteri, i collegi dei nobili giureconsulti e dei notai, i corpi dei militari, dai membri della confraternita di S. Giovanni Decollato (in veste bianca e a volto coperto), preceduti dal Capitano di Giustizia (indicato con il longobardismo Barigildus o Bargellus), e da un pubblico banditore. Ai lenti rintocchi della campana il condannato veniva condotto al luogo del supplizio attraverso un percorso che partiva dalla prigione, passava dalla chiesa di S. Girolamo (in via Sicardo), e si snodava poi attraverso il “Vicolo degli Impiccati” (detto Stricta de Apichatis, continuazione ora soppressa del vicolo S. Girolamo verso via Platina – segnata in rosso nella pianta a fianco), le attuali via XI Febbraio, via Manini e via S. Erasmo, sino al piazzetta dinanzi alla chiesa. Dal ‘600 circa il patibolo risulta invece collocato nella Platea Parva (attuale Piazza Stradivari) o Platea Capitanei, davanti ad una torre eretta a spese della città nel 1132, chiamata dal popolo Torre dei Ciabattini e, in seguito, Torre del Capitano (ancor oggi visibile, inglobata nell’edificio dell’ex Casa di Bianco). La torre aveva una sola campana, che veniva suonata, in concorso con la campana della torre comunale, per dare avviso ai cittadini di qualche esecuzione capitale. Lo spostamento del capestro si intuisce anche dal trasloco del Boia, la cui residenza era situata sino alla metà del ‘500 in via Palio dell’Oca (che si chiamava appunto “Contrada del Carnefice”), mentre dal 1560 circa risulta sistemata in alcuni locali sopra la Sala del Consiglio di Palazzo Comunale. Al proposito, il Cavalcabò riporta un fatto curioso: sembra infatti che quei locali fossero totalmente sprovvisti di servizi igienici, perché in una supplica datata 1569 alcuni vicini, stufi di prendersi in testa ogni tanto i bisogni del Boia (che, senza farsi troppi problemi, «gittava a basso la fece et altre sporchizie»), pregavano vivamente la Magnifica Comunità di trasferirlo altrove. La sua dimora fu in seguito destinata a spostarsi ancora varie volte: in via Cadore e poi in via Grado, in una comoda abitazione a due piani quasi all’incrocio tra le vie Bissolati e della Torre.
Salito il condannato al patibolo, tutti stavano trepidanti e quasi senza respiro; e, uscito ogni tentativo per richiamarlo a migliori sentimenti di pentimento, il condannato veniva collocato o sulla catasta per essere arso vivo o sospinto sotto la mannaia del boia per essere decapitato o strangolato. Alla Confraternita della Beata Vergine della Misericordia e di San Giovanni Decollato, fondata nel 1436 e con sede nella chiesa di S. Girolamo, era affidata l’assistenza ai condannati, sia, come si è già detto, l’accompagnamento al patibolo (in veste bianca e a volto coperto), sia la sepoltura. In genere i condannati a morte venivano tumulati nel Sepolcro detto “dei Francesi”. Ma coloro che venivano impiccati avevano una sepoltura “speciale”, dapprima nel cortiletto ai piedi del Torrazzo (il quale, sino alla fine del XIX secolo era detto appunto il Campo Santo) e, verso la seconda metà del ‘600, nella cappella della chiesa di S. Girolamo (il luogo è indicato da una lastra marmorea ancor oggi visibile, sulla quale si legge “Ius mortem, Deus vitam, Charitas sepulcrum”) e per questo la chiesa veniva detta anche “degli impiccati”.
Annota il Cavalcabò che un elenco completo dei giustiziati a Cremona non è stato tramandato, ma è certo che le esecuzioni erano frequenti (l’ultima registrata nelle delibere è datata il 30 novembre del 1827 e venne eseguita sugli spalti delle mura di via Pedone) e, in molti casi, anche alquanto crudeli. Oltre ai numerosi episodi di torture e di esecuzioni capitali del periodo comunale e signorile, se ne ricordano alcuni fra XVI e XVII secolo. Nell’ambito che sommariamente si potrebbe definire “stregoneria”, si ricordano intorno al 1582 le torture nei sotterranei del palazzo Vescovile che accompagnarono alcuni interrogatori della “strega” cremonese (ma di origini piacentine) Ursula Maggi, nell’ambito di un lungo processo (istruito dapprima davanti all’inquisitore domenicano Vincenzo Monte, poi a Cesare Marescalchi, vicario del vescovo Sfondrati) i cui atti sono stati recentemente riesumati, studiati e pubblicati. Quanto alle eresie, gli interventi erano condotti soprattutto nei confronti di seguaci delle dottrine riformate di Calvino e Lutero, che pensavano di trovare rifugio e aiuto proprio a Cremona (già sede nel Medioevo di una fiorente comunità càtara).
Quanto ai criminali “comuni”, dai documenti risulta come ancora tra ‘500 e ‘600 i condannati, oltre che impiccati, venissero anche decapitati, bruciati («arsi al focho»), fatti a pezzi («tenayati et squartati») pare iniziando dai piedi perché soffrissero di più, o giustiziati tramite fratture multiple causate da una ruota («arrotati»). Per lo più si trattava di assassini o banditi. Ma è riportato qualche caso singolare come quello di tali Domenico C. e Andrea D., mandati a morte perché sarebbero stati sorpresi con una donna vestita da uomo. Severe erano anche le pene che si rischiavano per reati “minori”: dalla documentazione d’archivio si viene a sapere come nel 1505 venisse «cavato un ogio» ad un tizio colpevole di furto; mentre per calunnie pubbliche di una certa gravità era «schiapata (tagliata) la lengua con una forbesina». E se il trapasso rappresentava l’ultimo patimento per l’anima del condannato, altrettanto non era per il corpo. Per intimorire il popolo, infatti, era frequente l’esposizione dei cadaveri al pubblico. Capitava così che gli impiccati fossero appesi due volte, o che ne venissero dilaniate le membra per essere messe a penzolare in un luogo diverso dal supplizio, in genere nelle contrade d’origine del giustiziato, come macabro ammonimento. Ma era soprattutto la Piazza Piccola (la Platea Minor o Platea Capitanei, attualmente Stradivari) ad essere designata, per ovvie ragioni di pubblico, all’esposizione dei corpi, offrendo uno spettacolo certo raccapricciante per i passanti, come raccapricciante, nella sua essenzialità, era la dicitura usata per indicare le esecuzioni nelle delibere del Consiglio della Magnifica Comunità di Cremona: «oggi forca».
Fotoservizio Gianpaolo Guarneri fotoStudio B12
© RIPRODUZIONE RISERVATA


























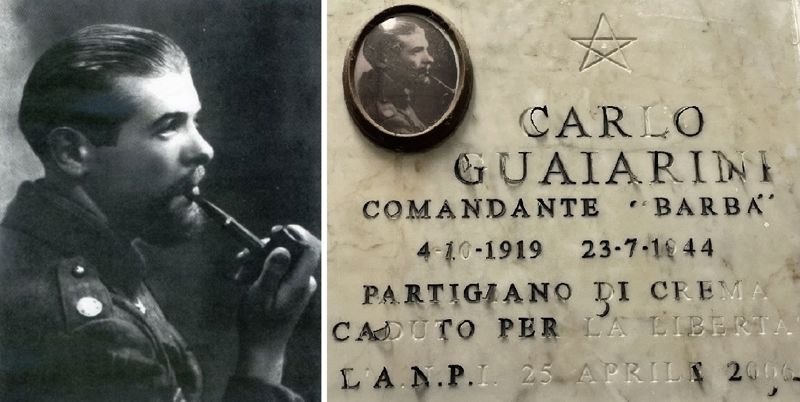


























commenti
Michele de Crecchio
28 febbraio 2025 19:17
Davvero singolare il quadretto "ex-voto" che l'ottimo Sindaco di Cremona, Emilio Zanoni, probabilmente ben consigliato da Alfredo Puerari, direttore del Civico Museo, fece esporre in bella vista all'interno del suo ufficio di "primo cittadino" e in posizione tale che tutti i "questuanti" che gli avevano chiesto udienza potessero ammirare il simpatico quadretto e trarne l'implicito ammonimento morale.
L'"ex-voto" era stato, tempo addietro, commissionato da un facoltoso condannato a morte per impiccagione, sotto il peso del corpo del quale, l'apposito cappio, "accuratamente" preparato dal boia, si era "miracolosamente" aperto..., così creando la necessaria premessa per la concessione della grazia da parte dell'autorità comunale.
Non credo che, chi, ricevuto in udienza da Zanoni ammirava tale simpatico ex-voto, ci mettesse poi molto, cittadino o funzionario comunale che fosse, a recepire il messaggio morale implicito nella singolare immagine.
Marco
1 marzo 2025 18:29
Bellissimo e interessante articolo, complimenti.
Grazie anche a Michele De Crecchio per l'aneddoto molto simpatico.
francesco
3 marzo 2025 07:34
Affascinante...non tutti i cremonesi conoscono queste curiosità
Michele de Crecchio
13 novembre 2025 18:31
La riapertura del vicolino (tuttora, credo, ancora privo di una denominazione toponomastica ufficiale) che collega la piazza del Comune con la piazza del Vescovato, fu eseguita agli inizi del secolo scorso, semplicemente demolendo le pareti che ne tamponavano le estremità e così creavano uno spazio chiuso utilizzato a scopo commerciale (in pratica, credo, si trattasse di una piccola osteria con annessa rivendita di vino) furono, a mio personale parere, uno dei pochi effettivi benefici provocati dalle complesse operazioni (prevalentemente di demolizione) che, all'inizio del secolo scorso, furono eseguite, con un entusiasmo certamente degno di miglior causa, sotto la denominazione di "isolamento del Duomo". L'impegno personale di Illemo Camelli, ispettore locale della Soprintendenza, era riuscito, in questo caso, a preservare dalla demolizione la modesta (quanto utile) costruzione che ancora oggi costituisce la delimitazione orientale del vicolino. Non pochi "sapientoni" cremonesi, ostinati sostenitori di una demolizione più estesa, si presero allora gioco del Camelli, attribuendo a tale piccola costruzione la scherzosa (e maligna) denominazione di "villino Camelli"!