Da Roncole a Vidalenzo, la storia dimenticata dei genitori di Giuseppe Verdi
L’occasione dell’anniversario della nascita del maestro Giuseppe Verdi è propizia, per cremonasera.it e per tutti i lettori, per ricordare due figure mai sufficientemente commemorate. Quelle da cui tutto ha preso origine, vale a dire i genitori del maestro, Luigia Uttini e Carlo Verdi, entrambi sepolti a due passi da Cremona, nel cimitero di Vidalenzo di Polesine Zibello (Parma). Un luogo simbolico, perché posto al confine tra Emilia Romagna e Lombardia e tra le province di Parma, Piacenza e Cremona, tutti luoghi particolarmente cari al Cigno ed assai legati alla sua memoria. Due figure, quelle dei genitori, va ribadito, troppo spesso poco considerate, poco commemorate, talvolta finite nel dimenticatoio quando invece meriterebbero ben più considerazione. Luigia Uttini e Carlo Verdi riposano lì, in una piccola cappella (di cui si pubblicano le immagini) all’ombra della chiesa parrocchiale di san Cristoforo. Lo stesso cimitero in cui, da pochi anni, riposa anche il maestro Carlo Bergonzi, ritenuto dalla critica il più grande tenore verdiano del Novecento, anche lui nativo di Vidalenzo. Venendo alla figura dei genitori del maestro, Luigia Uttini nacque a Saliceto di Cadeo, nel Piacentino, il 29 settembre 1787 e morì a Vidalenzo il 28 giugno 1851. Figlia di Carlo Uttini, oste di Saliceto di Cadeo, il 30 gennaio 1805 sposò Carlo Verdi nell’oratorio di Santa Maria Annunziata a Busseto e i due andarono poi a vivere a Roncole. Nel Registro delle nascite del Municipio di Busseto relativo al figlio Giuseppe, risulta essere “fileuse”, cioè filatrice. Il 10 ottobre 1813 diede alla luce Giuseppe Verdi ed il 22 marzo 1816 la secondogenita Giuseppa Francesca, morta in giovane età il 9 agosto 1833. Nel 1814 trovò rifugio nel campanile della chiesa parrocchiale di Roncole, con il suo piccolo Giuseppe, per sfuggire alle truppe russe ed austriache, nel turbolento periodo immediatamente successivo alla disfatta napoleonica. Episodio, questo, ancora oggi ricordato in una lapide posta alla base della torre campanaria. Intorno al 1830 ebbe qualche problema di salute e nel maggio del 1849 andò a vivere a Sant’Agata che lasciò nell’aprile 1851 quando vi si stabilì il Cigno e lei, col marito Carlo, si trasferì a Vidalenzo dove morì pochi mesi dopo, il 28 giugno 1851. Data, questa, sulla quale esiste anche un piccolo “giallo”: secondo alcune versioni sarebbe morta il 30 giugno (come si legge anche nella lapide di Vidalenzo), secondo altre (pare più accreditate) il 28 giugno. Il marito Carlo, di due anni più anziano, nacque alle Roncole il 28 agosto 1785 e morì il 14 gennaio 1867. Era figlio di Giuseppe Antonio Verdi e di Francesca Bianchi di Villanova sull’Arda. L’11 febbraio 1791 la famiglia prese in affitto, alle Roncole, l’Osteria vecchia, di proprietà del santuario di Madonna Prati che poi Carlo verdi mantenne fino all’11 novembre 1830. Il 30 gennaio 1805 si sposò appunto con Luigia Uttini e nello stesso anno incorse nei rigori della legge, accusato di aver permesso, nel suo locale, il gioco d’azzardo con le carte. Nel 1825 venne nominato Tesoriere della Fabbrica della chiesa di San Michele Arcangelo alle Roncole (quella in cui il figlio Giuseppe venne battezzato e dove mosse i primi passi nel mondo della musica sull’organo che ancora oggi si conserva ma è da tempo inutilizzato a causa della chiusura della chiesa per inagibilità)) e mantenne questo incarico fino al 1840. Nel 1830, per aver troppo ritardato il pagamento dell’affitto, venne sfrattato da un terreno di 48 biolche con annessa casa padronale in cui abitava e si trasferì a Busseto, dal 1848 nel Palazzo Orlandi acquistato dal figlio. Nel 1849 si trasferì con la moglie a Sant’Agata rimanendovi fino al 1851. In quell’anno il figlio Giuseppe, venuto a sapere che il padre si diceva amministratore o affittuario della residenza di Sant’Agata, scrisse al notaio Balestra: “non accondiscenderò a questi due progetti. Io intendo essere diviso da mio padre, di casa e di affari. Infine non posso che ripetere quanto le dissi ieri a voce; presso il mondo Carlo Verdi deve essere una cosa e Giuseppe Verdi un’altra” (testo del 21 gennaio 1851). La difficoltà nei rapporti con il padre e, in particolare, il prorompere di Antonio Barezzi nella vita di Giuseppe Verdi hanno sempre lasciato nell'ombra i genitori. Il padre Carlo sostenne il figlio nei primi anni di carriera, ma dopo i successi e la notorietà raggiunte dal figlio stesso, pretese di amministrarne il cospicuo capitale. Questo portò ad una brusca rottura dei rapporti fino allo strappo definitivo del 1851. Il Cigno dispose comunque, per i genitori una piccola pensione, e loro si trasferirono a Vidalenzo, dove Luigia Uttini morì, come anticipato, poco dopo (il 28 giugno 1851). Carlo Verdi tornò allora a Busseto e già l’anno successivo accusò problemi di salute con Emanuele Muzio (unico allievo di Giuseppe Verdi) che in una lettera a Tito Ricordi del 26 aprile 1852 scriveva “Speriamo che Iddio voglia risparmiare a Verdi l’immenso dolore di perdere il padre suo!”. Nel 1865 la situazione peggiorò ancora e Giuseppe Verdi, il 5 aprile di quell’anno, ad Arrivabene scriveva “il mio povero padre è sempre nello stesso stato. Io vorrei pure sperare nella buona stagione ma il male è grave, e l’età troppa” e venti giorni più tardi, sempre ad Arrivabene scriveva che il padre si era aggravato mentre due giorni dopo sempre in un suo scritto evidenziava che “la febbre, benchè leggerissima non l’abbandona mai: nonostante un pericolo imminente non c’è”. Carlo Verdi morì il 14 gennaio 1867, e Verdi, ancora ad Arrivabene, da Parigi, l’8 febbraio 1867 scrisse: “avrei voluto chiudere gli occhi a quel povero vecchio, e sarebbe stato un sollievo per Lui e per me!”. Giuseppina Strepponi il 18 gennaio di quello stesso anno scriveva: “Verdi ne è addoloratissimo, ed io, ad onta che abbia vissuto pochissimo con lui, e fossimo agli antipodi nel modo di pensare, ne sento vivissimo rammarico e forse tanto vivo quello di Verdi”. Parroco di Vidalenzo negli anni in cui Luigia Uttini e Carlo Verdi vissero a Vidalenzo era don Giovanni Avanzi, amico di famiglia dei coniugi Giuseppe Verdi e Giuseppina Strepponi e, come noto, era spesso loro ospite nella Villa di Sant’Agata. E’ molto probabile, anche se non esistono conferme ufficiali, che a dettare le lapidi obituitarie dei genitori del maestro, sia stato proprio don Avanzi. Senza dimenticare infine la piccola località di Ongina, di fatto parte integrante di Vidalenzo, dove le tracce verdiane sono significative e, in questo caso, si rimanda all’articolo pubblicato qui .
Infine, sempre per quanto riguarda il maestro, le sue origini, la sua vita e le sue opere, è ora tutto pronto in vista delle Giornata d’Autunno del Fai in occasione delle quali, sabato 11 e domenica 12 ottobre, riaprirà eccezionalmente la Villa Verdi di Sant’Agata che dal 17 dicembre 2024 è di proprietà statale dopo che il Ministero della Cultura ha ufficialmente firmato il decreto di esproprio per la Villa e le sue pertinenze. Con questo provvedimento, lo Stato ha sancito l’acquisizione definitiva della storica dimora, garantendone la salvaguardia e restituendola alla collettività come patrimonio culturale condiviso. Ma è altrettanto vero che da allora, nonostante i lavori realizzati negli ultimi mesi, nessun turista ha più messo piede oltre i cancelli, sempre chiusi della celebre dimora. La villa, per farla breve, è rimasta chiusa negli ultimi due anni a causa di una lunga disputa giudiziaria tra gli eredi e lo Stato (disputa che per altro non si è ancora chiusa). L’indennizzo proposto agli eredi ammonta a otto milioni di euro e secondo il Ministero l’acquisizione costituisce un passo essenziale per la tutela, la conservazione e la valorizzazione di uno dei luoghi più rappresentativi della cultura e della storia musicale italiana. Sabato 11 e domenica 12 ottobre, in occasione della ricorrenza della nascita del celeberrimo musicista e compositore Villa Verdi riaprirà appunto al pubblico per le Giornate Fai d'Autunno. Sarà una visita unica ed eccezionale, curata dai volontari della delegazione piacentina del Fai. Apertura straordinaria ed eccezionale, appunto. In questo luogo raccolto e solitario Verdi, che frequentava abitualmente Cremona e la fece diventare, di fatto, il principale luogo dei suoi affari, visse a lungo, traendo ispirazione per le sue composizioni e seguendo personalmente la gestione dei poderi. La villa conserva immutato il fascino di quel periodo e nel parco risaltano molte delle alberature scelte e messe a dimora dal celebre musicista. I terreni su cui sorge la villa furono acquistati dal maestro nel 1848. Il podere, di circa tre ettari, apparteneva in precedenza alla famiglia Merli e comprendeva solo campi e un semplice edificio padronale. Verdi diede personalmente istruzioni per la costruzione della nuova villa e ne seguì i lavori, che durarono circa tre anni. Nel 1851 Verdi lasciò Busseto, dove aveva risieduto a Palazzo Orlandi in attesa della sistemazione della villa, e si trasferì a Sant'Agata insieme a Giuseppina Strepponi, la soprano interprete di alcune tra le sue prime opere, con la quale si sposò in seconde nozze nel 1859 (la prima moglie Margherita, figlia del suo mecenate Antonio Barezzi, era morta nel 1840). Nel 1870, per inciso, il Cigno divenne anche proprietario della Cascina Gerre del Sole a Stagno Lombardo. Villa Verdi fu la residenza prediletta del maestro, dove amava riposarsi di ritorno dai suoi viaggi e dove compose le opere della maturità artistica (La forza del destino, Don Carlos, Aida, Otello, Falstaff e altre). All'attività artistica Verdi affiancò sempre uno spiccato interesse per la campagna, dedicandosi con sempre maggiore passione alla conduzione delle sue terre e all'allevamento del bestiame. Nato all'epoca in cui Roncole di Busseto era sotto il dominio francese, Verdi fu come è noto molto attivo nella vita politica nazionale: patriota e sostenitore dei moti risorgimentali, venne chiamato a far parte del primo parlamento italiano e poi nominato senatore. A Sant'Agata e nel territorio circostante, che considerava le sue terre, Verdi possedette vari poderi, e si impegnò in iniziative sociali. Nel 1879, dopo il matrimonio della figlia adottiva Filomena Maria, rivestì anche la carica di consigliere a Villanova sull'Arda, dove contribuì alla costruzione dell'ospedale, attualmente chiuso e al centro (nell’area adiacente, non nello storico edificio voluto, fondato e pagato dal maestro) dei lavori di realizzazione del Centro Paralimpico del Nord Italia (Verdi lo aveva voluto, come da disposizioni testamentarie, per i poveri ed i bisognosi della zona, ma a quanto pare anche il testamento di uno dei più importanti personaggi della storia d’Italia non ottiene particolare rispetto). Giuseppina Strepponi morì a Villa Verdi nel 1897, mentre il compositore si spense quattro anni dopo a Milano in una camera da lui utilizzata abitualmente sin dal 1872, del Grand Hotel et de Milan, dove aveva scelto di passare l'inverno. Cosa si scoprirà durante le Giornate d’Autunno del Fai? Le stanze di Giuseppe Verdi e Giuseppina Strepponi, ricche di mobili pregiati, effetti personali e documenti legati alla loro vita e alle opere del maestro, sono ancora oggi accuratamente conservate e sono comprese nel percorso di visita, che comprende anche una la ricostruzione, con i mobili originali, della camera del Grand Hotel et de Milan frequentata a lungo da Verdi. Il giardino prese forma sempre sotto la guida di Verdi, che si ispirò allo stile romantico in voga in quel periodo. Il 'giardino della Peppina', come venne inizialmente chiamato lo spazio dove la compagna di Verdi scelse di coltivare bulbose e altre piante da fiore, venne in seguito ampliato e arricchito degli scenografici ambienti tipici del parco all'inglese, come il laghetto, con una piccola isola raggiungibile in barca e un romantico ponticello, e la grotta artificiale. Le piante vennero disposte a formare macchie arboree di aspetto naturale, attraversate da vialetti sinuosi, impiegando specie di spiccato valore ornamentale come il cipresso calvo e il noce del Caucaso. La villa, recentemente acquisita dal Ministero della Cultura, da alcuni anni non è aperta al pubblico e versa in condizioni di conservazione non ottimali; il Ministero sta avviando importanti lavori di restauro e adeguamento per preservare e valorizzare questo luogo straordinario. Le visite dell’11 e 12 ottobre saranno a cura di Soprintendenza Abap per le province di Parma e Piacenza, Volontari Fai (Delegazione di Piacenza, Gruppo FAI Giovani, Gruppo FAI Monticelli d'Ongina, Gruppo FAI Bobbio). Sempre a riguardo della villa, proprio in questi giorni, il ministro della cultura Alessandro Giuli, a margine dell'inaugurazione della mostra "Bella figura, Pittura Italiana d'oggi" al Complesso Monumentale della Pilotta a Parma, ha detto: "Su Verdi ci prepariamo a darvi molte soddisfazioni, perché lavoreremo sugli itinerari verdiani, quindi da villa Verdi fino a Busseto e ad altri luoghi in cui la vita del maestro si è dispiegata in tutta la sua grandezza per dare un'offerta integrata di cultura verdiana che non sia circoscritta alla villa su cui pure abbiamo appena stanziato diversi milioni di euro". Il ministro, tra l’altro, era già stato in visita alla villa nel corso dell’estate. Infine un consiglio a tutti coloro che in questi giorni, da Cremona e non solo, si recheranno a Sant’Agata: fate un salto anche nella vicinissima Vidalenzo e, al cimitero, in silenzio, portate un fiore, o un lume, anche ai genitori del maestro.
Eremita del Po
© RIPRODUZIONE RISERVATA


























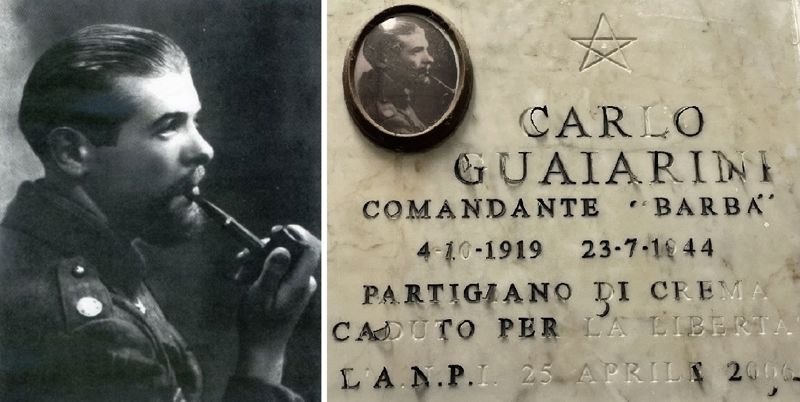

























commenti
marco
11 ottobre 2025 11:58
Un racconto interessante che svela particolari e luoghi che i più (e mi metto anch'io io) non conoscono.
Grazie.
Lilluccio Bartoli
12 ottobre 2025 09:51
Nel pulviscolo della storia sai tracciare una spera e rendere visibili quegli impercettibili granelli sospesi, li sai cogliere, descrivere e porgere ben confezionati al lettore che poi scarta arricchendosi di storia, cultura, vita.